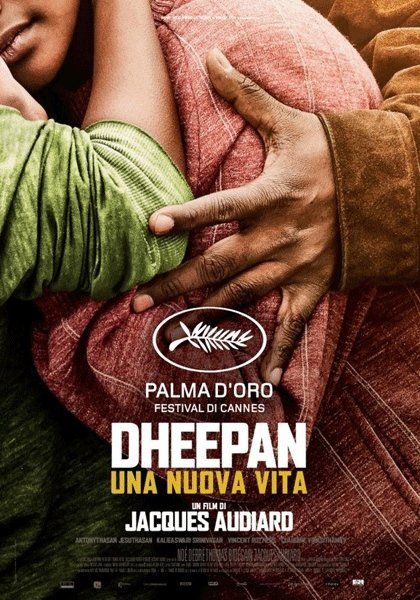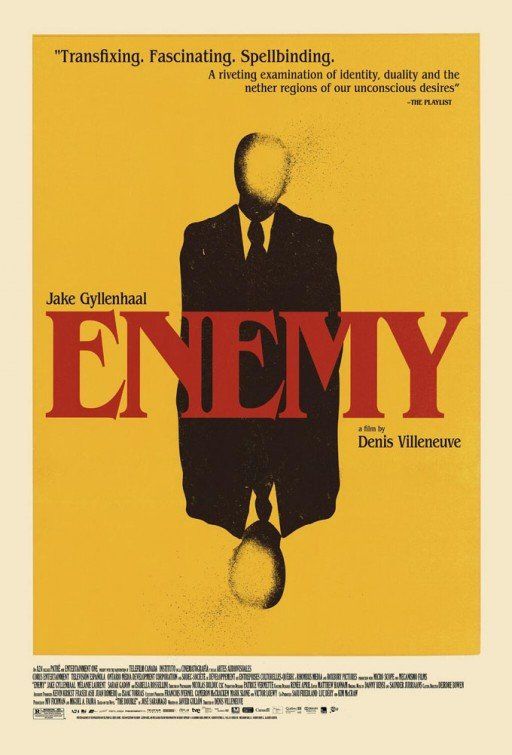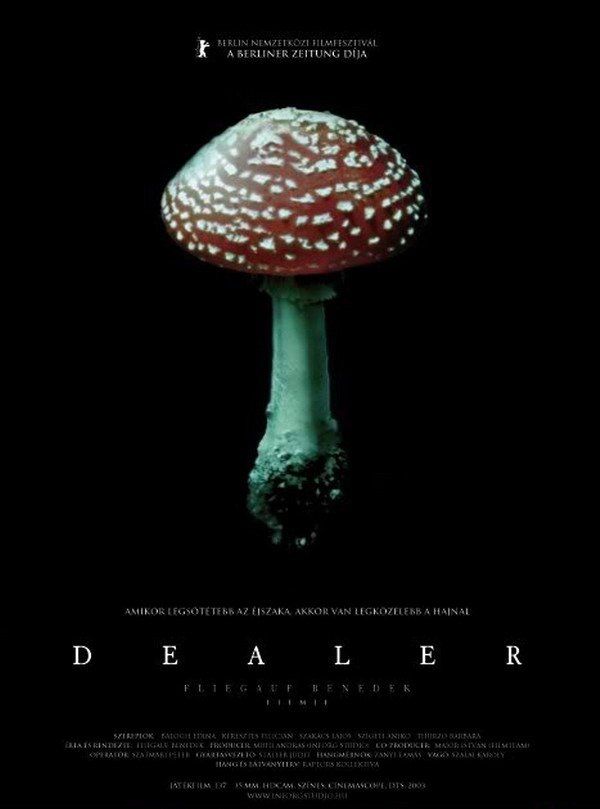“Mattino del 1º gennaio, il telefono squilla. Murphy si sveglia accanto
alla giovane moglie e al figlio di due anni. Ascolta un messaggio
lasciato alla segreteria telefonica: tremendamente angosciata, la madre
di Electra vuole sapere se Murphy ha notizie di sua figlia scomparsa da
tempo, poiché teme che le sia capitato qualcosa di grave. Nel corso di
una lunga giornata piovosa, Murphy si ritrova solo nel suo appartamento a
ricordare la sua più grande storia d’amore: due anni con Electra. Una
passione ardente piena di promesse, giochi, eccessi ed errori…” (dal
presskit).

Nel
corso degli anni ho sognato di fare un film che riproducesse al meglio
la passione amorosa di una giovane coppia in tutti i suoi eccessi fisici
ed emotivi. Una sorta di amour fou simile alla quintessenza di ciò che i
miei amici o io stesso abbiamo potuto vivere. Un melodramma
contemporaneo in grado d’integrare molteplici scene d’amore e capace di
superare la ridicola barriera che impedisce di mostrare sequenze
apertamente erotiche in un film normale (…). Volevo filmare ciò che il
cinema, per ragioni commerciali o legali, può permettersi raramente,
vale a dire filmare la dimensione organica dello stato amoroso. Eppure,
nella maggioranza dei casi, è qui che risiede l’essenza stessa
dell’attrazione all’interno di una coppia. Il partito preso consisteva
quindi nel mostrare una passione intensa sotto una luce naturale, dunque
animale, ludica, orgasmica e lacrimale. Contrariamente ai miei progetti
precedenti, per una volta non si tratta che di violenza sentimentale ed
estasi amorosa.
Affaire Love

La prima questione da affrontare senza indugi nell’
affaire Love
riguarda l’assegnazione a scoppio ritardato del divieto ai minori di 18
anni (nelle prime due settimane di programmazione, il film è uscito in
33 sale francesi con un divieto ai minori di anni 16). Non tanto per
capriccio morboso o per un’indignata difesa della libertà di
espressione, quanto per mettere in evidenza un’anomalia che interessa
attualmente il sistema francese di assegnazione dei visti di
distribuzione cinematografica (
Visa d’exploitation).
Come funziona questo sistema? L’organo consultivo deputato
all’assegnazione dei visti è, in prima istanza, la Commissione di
classificazione delle opere cinematografiche (
Commission de classification des œuvres cinématographiques):
se non insorgono complicazioni, l’indicazione proposta dalla
commissione viene pacificamente approvata dal Ministero della Cultura e
della Comunicazione che, per mano del ministro, la conferma e la rende
effettiva. Questa la prassi consolidata da decenni. Ora, dal momento che
la commissione di classificazione è diretta emanazione del Centro
Nazionale del Cinema e dell’Immagine Animata (
CNC)
ed è composta in maggioranza da professionisti che operano nel settore,
le indicazioni che essa suggerisce, improntate al rispetto delle opere e
alla protezione della creazione artistica, possono essere considerate
eccessivamente permissive e indulgenti, se non addirittura lassiste, da
chi reclama un’applicazione letterale e draconiana della legge in
materia (
l’articolo 227-24
del Codice penale francese proibisce formalmente la diffusione ai
minori di un messaggio “a carattere violento, pornografico, incitante al
terrorismo o di natura tale da offendere gravemente la dignità umana”,
contemplando la punizione a tre anni di reclusione e la sanzione
pecuniaria di 75000 euro).

È
proprio questa discrezionalità della commissione, una discrezionalità
rispettosa delle opere e ragionevolmente duttile nell’applicazione della
normativa in materia, a prestare il fianco alle controversie. Eppure
l’anomalia non risiede nella presunta elasticità della commissione di
classificazione - che per le frange più reazionarie equivale al lassismo
- o in un ipotetico richiamo all’inflessibile applicazione della legge
da parte del ministero, poiché il più delle volte quest'ultimo si limita
ad avallare le indicazioni suggerite dalla prima. L’anomalia consiste
invece nell’eventualità che una terza parte, reclamando maggior rigore
applicativo, contesti la correttezza del visto erogato dagli organi
competenti e interpelli altri organi istituzionali (il tribunale
amministrativo e, in ultima istanza, il Consiglio di Stato) per
procedere a un riesame del film e all’attribuzione di una
classificazione più severa. Perché parlo di anomalia e non di semplice
risorsa democratica? Perché negli ultimi anni
Promouvoir,
un’associazione cattolica fondata nel 1996 la cui finalità consiste
nella “promozione dei valori giudaico-cristiani in tutti i domini della
vita sociale”, ha più volte contestato le decisioni di commissione e
ministero, ottenendo più volte dal Consiglio di Stato la revoca dei
visti ministeriali e l’assegnazione di classificazioni più rigorose (dal
divieto ai minori di 16 anni al visto “X” o all’interdizione ai minori
di 18) per pellicole quali
Baise-moi (1999), Ken Park (2003), Saw 3D (2010), Nymphomaniac (2013) e, appunto,
Love.

In sostanza, la situazione attuale è questa: l’associazione di estrema destra
Promouvoir, capitanata dall’avvocato omofobo e ultratradizionalista
André Bonnet,
tiene sotto scacco il Ministero della Cultura e la Commissione di
classificazione del CNC, attaccando le loro deliberazioni ogni qual
volta le giudichi troppo permissive o condiscendenti. Questa situazione,
definita da Vincent Maraval, patron di Wild Bunch, vero e proprio
“terrorismo morale” ha accompagnato la vicenda di
Love
fin dall’inizio, giacché il ministro (o la ministra che dir si voglia)
della cultura in carica Fleur Pellerin, prevedendo la reazione di
Promouvoir,
non ha avallato la prima raccomandazione della commissione di vietare
il film ai minori di 16 anni, ma, caso rarissimo, ha chiesto alla
commissione stessa di riesaminare il film con l’auspicio di ottenere una
classificazione più severa. Oltre all’evidente cerchiobottismo del
ministro (perché non ha semplicemente scelto di non seguire
l’indicazione, anziché chiedere alla commissione di cambiare parere?),
si spalanca una questione letteralmente surreale:
che senso ha mantenere in vita un’apposita commissione
composta in maggioranza da professionisti del settore, se a stabilire
la classificazione delle pellicole è in ultima analisi un’associazione
reazionaria?

Cionondimeno,
per la seconda volta e con regolare votazione, la commissione ha
confermato il divieto ai minori di 16 anni senza lasciarsi influenzare
dalla richiesta di revisione del ministro o farsi intimidire dalle
prevedibili reazioni di
Promouvoir. Reazioni che, naturalmente, non si sono fatte attendere:
Love
è uscito nelle sale francesi mercoledì 15 luglio col divieto ai minori
di 16 anni e il giorno successivo l’associazione di André Bonnet ha
richiesto un provvedimento d’urgenza al Tribunale Amministrativo di
Parigi per contestare il visto di distribuzione del film. Il nuovo esame
(e siamo a quota tre) del tribunale amministrativo ha sospeso, in data
giovedì 30 luglio, il visto ministeriale e, in ragione della presenza
nel film di “scene di sesso non simulate”, ha ufficialmente innalzato il
divieto ai minori di 18 anni, non senza qualche complicazione per le 33
sale che stavano programmando
Love da due settimane
con la classificazione improvvisamente annullata. La parola finale è
comunque spettata alla più alta corte amministrativa francese: il
Consiglio di Stato, interpellato con un ricorso in cassazione presentato
nel mese di agosto dalle società di produzione e distribuzione del
film, nonché dal gabinetto del ministro Fleur Pellerin, che nel
frattempo ha assunto posizioni meno cerchiobottiste, difendendo con
prudenza ma sempre più apertamente -
a 20:48 si parla del film di Noé e della temibile associazione di Bonnet - la libertà di creazione artistica e l’operato della commissione di classificazione. L’affaire
Love
si chiude definitivamente mercoledì 30 settembre quando, esaminato
nuovamente il film lunedì 14 settembre (quarto vaglio istituzionale in
poco meno di tre mesi: un autentico record), il Consiglio di Stato
respinge il ricorso e conferma il divieto ai minori di 18 anni con la
seguente
motivazione:
“il giudice dei provvedimenti d’urgenza del tribunale amministrativo
non ha commesso errore sospendendo parzialmente il visto di
distribuzione in base al fatto che
Love avrebbe dovuto essere
vietato ai minori di 18 anni (senza classificazione “X”) in ragione
delle numerose scene di sesso non simulate che esso comporta”.

Tirando
le somme, l’intera controversia sorta intorno all’ultimo film di Gaspar
Noé ha finito per concentrarsi sulla presenza di “scene di sesso non
simulate” (l’articolo
R. 211-12
del Codice del cinema e dell’immagine animata prevede difatti il
divieto ai minori di 18 anni nel caso in cui l’opera comporti scene di
tale natura), sollevando un importante problema di carattere normativo.
Dal momento che questo criterio grossolanamente quantitativo e
automatico (presenza di scene di sesso non simulate = divieto ai minori
di 18) risulta palesemente inadeguato alla realtà contemporanea, da una
parte per la frequenza sempre maggiore di film comprendenti scene di
sesso esplicito a finalità non masturbatoria (basti pensare a pellicole
di Catherine Breillat, Bruno Dumont, Bertrand Bonello, Philippe
Grandrieux, Jean-Claude Brisseau, Alain Guiraudie e Abdellatif Kechiche)
e, dall’altra, per il ruolo sempre più marginale del cinema nella
formazione sessuale degli adolescenti (ruolo rimpiazzato dal possesso di
un dispositivo informatico e dall’accesso a un motore di ricerca
qualsiasi), il solo modo di correggere l’anomalia del sistema di
classificazione risiede nella revisione dei criteri che disciplinano la
regolamentazione. A fare problema, insomma, è la necessità sempre più
stringente di stabilire una distinzione tra scene di sesso non simulate e
scene a vocazione dichiaratamente pornografica. È per questo motivo
che, sulla scorta dell’affaire
Love, il ministro della cultura Fleur Pellerin ha annunciato l’avvio di una
riflessione per la riforma del sistema concertata con la commissione di classificazione, con
rappresentanti del mondo del cinema,
specialisti nella protezione della gioventù e neuropsichiatri
infantili. Entro gennaio 2016 Jean-François Mary, presidente della
commissione del CNC, dovrà presentare al ministro delle proposte
pianificate per l’elaborazione di una regolamentazione più adatta alla
realtà cinematografica attuale. In definitiva l’affaire
Love, in maniera non troppo dissimile dall’affaire
Baise-moi
(in seguito al quale è stato reintrodotto il divieto ai minori di 18
anni, precedentemente sospeso dal ministro della cultura Jack Lang),
avrà con ogni probabilità decisive ripercussioni sull’intero sistema
francese di classificazione delle opere cinematografiche.
 Malgrado
il suo piccolo budget, questo film colorato dal formato cinemascope è
stato girato in rilievo grazie a nuove videocamere. Spero che questa
scelta renderà l’esperienza più immersiva per gli spettatori.
Affascinato dalle immagini in rilievo, continuo da anni a scattare foto
in 3D, analogiche o digitali. La posta in gioco è ancora più inquietante
quando si filma una persona cara la cui vita sta svanendo. Rivedendo le
immagini, si ha la sensazione di aver trattenuto una parte quasi
vivente della persona dentro una piccola scatola. Il rilievo dà
l’impressione illogica e infantile di aver afferrato un momento del
passato molto meglio di quanto possa farlo un’immagine piatta. Siccome
questo film racconta un amore perduto, ho pensato che il rilievo potesse
aumentare l’identificazione dello spettatore col personaggio e la sua
condizione nostalgica. Analogamente, la presenza di una voce over o la
scelta delle musiche sono lì per riflettere meglio lo scacco emotivo del
protagonista, tanto smarrito nei suoi atti quanto nei suoi pensieri.
Malgrado
il suo piccolo budget, questo film colorato dal formato cinemascope è
stato girato in rilievo grazie a nuove videocamere. Spero che questa
scelta renderà l’esperienza più immersiva per gli spettatori.
Affascinato dalle immagini in rilievo, continuo da anni a scattare foto
in 3D, analogiche o digitali. La posta in gioco è ancora più inquietante
quando si filma una persona cara la cui vita sta svanendo. Rivedendo le
immagini, si ha la sensazione di aver trattenuto una parte quasi
vivente della persona dentro una piccola scatola. Il rilievo dà
l’impressione illogica e infantile di aver afferrato un momento del
passato molto meglio di quanto possa farlo un’immagine piatta. Siccome
questo film racconta un amore perduto, ho pensato che il rilievo potesse
aumentare l’identificazione dello spettatore col personaggio e la sua
condizione nostalgica. Analogamente, la presenza di una voce over o la
scelta delle musiche sono lì per riflettere meglio lo scacco emotivo del
protagonista, tanto smarrito nei suoi atti quanto nei suoi pensieri.
Love Affair

Il
lungo preambolo sulla controversia legale non costituisce una semplice
curiosità, poiché, oltre a mettere in luce le peculiarità del sistema
francese di assegnazione dei visti, evidenzia uno dei tratti distintivi
di
Love, anzi forse il suo tratto più saliente, ovvero l’inscindibilità della componente erotica da quella narrativa e sentimentale (
Love is Noé’s attempt to marry sex and story).
In maniera ancor più marcata e indissociabile di quanto avveniva in
alcune pellicole di Catherine Breillat, Bruno Dumont, Philippe
Grandrieux o Jacques Nolot, nell’ultimo film di Gaspar Noé
configurazione narrativa, modulazione sentimentale e rappresentazione
erotica sono visceralmente, geneticamente inseparabili: è letteralmente
impossibile alterare uno solo di questi aspetti del film senza
snaturarlo completamente o intaccarne in profondità la fisionomia
complessiva. Ed è proprio questa omogeneità di fondo, simile a un'osmosi
molecolare, ad aver posto il problema della classificazione in termini
cogenti e ineludibili. In questo senso uno dei punti di riferimento di
Love è
The Defiance of Good
(1975) di Armand Weston (la locandina del quale campeggia su una parete
della camera di Murphy), uno dei rari porno-horror degli anni ’70 in
cui progressione drammatica, sessualità esplicita e tensione emotiva non
seguono percorsi divergenti e discordanti, ma si integrano
congiuntamente ed efficacemente nel disegno narrativo.

L’origine di
Love risale a più di quindici anni fa, precisamente al periodo successivo a
Seul contre tous (1998), quando Gaspar Noé, impossibilitato a realizzare in tempi brevi
Enter the Void
per motivi tecnici, economici e logistici, decide di posporre
provvisoriamente il progetto e ripiegare su un piccolo film intimista,
una storia d’amore con copiosa rappresentazione del sesso sullo schermo.
Un giorno del giugno 2001 Noé incrocia Vincent Cassel in un locale e
gli parla del nuovo progetto, salutato da quest’ultimo con entusiasmo e
intraprendenza (sia Cassel che la moglie Monica Bellucci apprezzavano i
lavori precedenti di Noé), fissando nel mese di agosto il periodo adatto
alle riprese. Noé e Cassel interpellano dunque i due produttori Richard
Grandpierre e Christophe Rossignon (
L’odio,
Il patto dei lupi),
che si dicono realmente interessati alla proposta, e la produzione del
film inizia a ingranare con Studio Canal come compagnia di sostegno. Ma
quando Vincent e Monica leggono il trattamento di sette pagine prive dei
dialoghi (da improvvisare totalmente durante le riprese) vengono
spaventati dall’eccessiva intimità della vicenda, revocando la loro
partecipazione al film. Per non perdere la favorevole congiuntura
produttiva, Noé propone allora di realizzare un altro film, un
rape and revenge raccontato al contrario: è così che dalle ceneri di
Danger (il titolo originale del trattamento rifiutato) nasce
Irréversible (2002). Grazie al successo commerciale di
Irréversible, Noé può finalmente girare
Enter the Void,
pellicola molto più costosa e molto meno fortunata dal punto di vista
degli incassi. A sedici anni di distanza, infine, Noé ritorna al
trattamento di Danger, che diventa
Love.

Film dal budget decisamente meno impegnativo di
Enter the Void (costato più di 10 milioni di euro),
Love
(costato tra i 2 e i 3 milioni di euro) è stato realizzato grazie a una
coproduzione con investimenti privati che ha visto tra i principali
artefici Vincent Maraval di Wild Bunch: a questa rischiosa sinergia si
sono aggiunti in extremis gli aiuti del CNC per l’utilizzo del 3D (
aide aux nouvelles technologies en production).
Preparato e portato a termine in soli 9 mesi (da settembre 2014 a
maggio 2015) e proiettato in anteprima in un’affollatissima
Séance de minuit al 68º Festival di Cannes,
Love
è stato girato in 3D per più motivi: in primo luogo perché Noé aveva
già dimestichezza con questa tecnica (da anni scatta fotografie
stereoscopiche con un piccolo apparecchio e registra immagini in rilievo
con una videocamera Panasonic 3D a basso costo, videocamera che
peraltro viene utilizzata in una
sequenza iperstereoscopica
del film); in secondo luogo, importante quanto il primo se non di più,
poiché Benoît Debie, direttore della fotografia di fiducia di Noé a
partire da
Irréversible, aveva appena finito di girare
Every Thing Will Be Fine e, forte dell’esperienza acquisita sul set di Wim Wenders, ha convinto l’amico Gaspar che realizzare
Love
in 3D sarebbe stato meno complicato del previsto (grazie a un sistema
ottico stereoscopico più leggero di quello utilizzato per il film di
Wenders).

Sulle pagine del quotidiano elvetico
Le Temps, Marie-Claude Martin scrive: “Come
Irréversible che raccontava una storia di stupro al contrario,
Love
è una macchina per risalire il tempo. Come sempre, Gaspar Noé cerca
l’origine, questo tempo originario in cui niente è stato ancora
alterato, nel quale tutto è puro, semplice, infantile. Solo il ritorno
all’indietro e su di sé permette di raggiungere - sapendolo
definitivamente perduto - questo stato precedente alla corruzione”.
L’osservazione di Marie-Claude Martin coglie perfettamente nel segno:
se per Noé “il tempo distrugge tutto” (
Le Temps Détruit Tout),
la sola risorsa a disposizione per contrastare o sospendere questa
opera devastatrice risiede nello sfaldamento, nello smantellamento della
linearità cronologica e nella regressione verso il luogo immaginario e
primordiale dell’origine, là dove ogni cosa è colta
in statu nascendi,
nel momento aurorale del suo manifestarsi. L’inversione diviene una
figura della regressione allo stato anteriore alla degradazione e al
disfacimento: i finali di
Irréversible,
Enter the Void e
Love,
tre pellicole concepite più o meno nello stesso periodo e
indissolubilmente legate tra loro, rispondono a questa logica
regressiva, amniotica e lustrale. L’epilogo nella vasca da bagno di
Love,
benché suscettibile di una lettura simbolica d’impronta mortuaria (le
tonalità purpuree che impregnano l’inquadratura, il freeze frame
cadaverico che paralizza i corpi avvinghiati e la didascalia-epitaffio
THE END a caratteri cubitali), conclude quella che potrebbe essere
plausibilmente definita “trilogia della regressione”. Una trilogia che,
per quanto contraddistinta dallo stesso movimento retrogrado, porrebbe
di volta in volta l’accento su elementi diversi della dinamica
regressiva: la violenza in
Irréversible, la morte in
Enter the Void e, infine, il sentimento amoroso in
Love. Non è affatto fortuito che Noé, interpellato sull’influenza esercitata da
2001: Odissea nello spazio e da Kubrick in generale sul suo cinema, abbia risposto in questi termini: “
2001: Odissea nello spazio
è un film sensoriale, ma è soprattutto un film molto cerebrale,
meccanico, che sviluppa un discorso sull’umanità, sull’intelligenza
artificiale e altre cose ancora. I miei film sono molto mammiferi, i
suoi sono più costruiti con la neocorteccia, dunque la parte del
cervello che serve al linguaggio e alla previsione del futuro, i miei
film parlano più delle pulsioni mammifere - o rettili - dell’uomo e
della donna”.

Ancora Marie-Claude Martin: “E il 3D, direte voi? Contro ogni aspettativa, è la bella sorpresa di
Love.
Venduta come la promessa allettante di un’immersione totale, il 3D è
meno un invito al voyeurismo che uno scrigno protettivo. […] Il 3D ha la
stessa funzione: offrendo l’artificio di una profondità di campo,
mettendo i corpi in rilievo, giocando sull’aspetto teatrale, mette a
distanza più di quanto ci faccia penetrare nell’intimità dei corpi. I
quali, bagnati da una luce alonata, sono come protetti dagli sguardi che
potrebbero sporcarli”. Girato con un sistema a due videocamere 3D,
Love
deve praticamente tutta la concezione del suo impianto visivo
all’arrangiamento tridimensionale: impossibile afferrare e comprendere
completamente la strutturazione spaziale delle inquadrature, la
collocazione dei punti macchina, la gestione delle distanze tra i
personaggi e la resa volumetrica dei corpi con una visione 2D. Giusto a
titolo di esempio: quella che potrebbe sembrare una scelta squisitamente
stilistica come la predilezione per le inquadrature fisse e l’uso
parsimonioso dei movimenti di macchina è invece il precipitato estetico
della tecnica di ripresa (dal momento che in 3D i movimenti di camera
risultano eccessivamente vertiginosi e nauseanti, Gaspar Noé e Benoît
Debie, entrambi anche interpreti nei panni del gallerista Noé e dello
sciamano Yuyo, hanno rinunciato ai virtuosismi cinetici di
Enter the Void
e hanno al contrario adottato una misura visiva adatta a esaltare la
profondità di campo e l’iscrizione statuaria dei corpi nello spazio).
Detto più chiaramente, la sola versione di
Love in cui
il film canta e incanta è quella in 3D: lo “scrigno protettivo” di cui
parla Marie-Claude Martin, uno scrigno che mette al riparo la visione
dal sentimentalismo e dal voyeurismo, viene schiacciato e frantumato
dall’appiattimento della versione bidimensionale (altro esempio
emblematico: nella versione 3D, la frequente collocazione di Murphy/Karl
Glusman nella soglia tra due stanze possiede naturalezza e spontaneità,
mentre in quella bidimensionale acquista un artificioso sapore di
incorniciatura metacinematografica).

Strutturato sull’esperienza del ricordo di Murphy (l’espediente narrativo che permette a Noé lo zigzagante percorso a ritroso),
Love
abbraccia deliberatamente codici visivi che si discostano in modo
eclatante dal canone pornografico: anziché concentrarsi esclusivamente
sui genitali e sui particolari prestazionali, le inquadrature concedono
ampio respiro all’integralità fisica (la scena di apertura sulle note
della
Gnossienne nº 3 di Satie, la sequenza del
threesome su quelle di
Maggot Brain
dei Funkadelic), si assestano sulle parti superiori dei corpi
(l’amplesso che segue al “Can you show me how tender you can be?”
sussurrato da Electra/Aomi Muyock a Murphy sulle note
dell’indimenticabile
Lucifer Rising Take Two
di Bobby Beausoleil) oppure si stringono addirittura sui soli volti
ripresi in primo piano (Murphy e la sua ex Lucile/Xamira Zuloaga intenti
a baciarsi sulle note di
Always Returning
di Brian Eno). Contrariamente a quanto ipotizzato nelle fasi di
scrittura e preparazione (inizialmente Noé avrebbe voluto fare un film
pressoché privo di dialoghi, con sole musiche di accompagnamento e voce
over di Murphy), grande spazio è stato lasciato all’improvvisazione, sia
nelle parti dialogate (si pensi al feroce litigio nel taxi tra Murphy
ed Electra) che in quelle performative (la sequenza, già divenuta di
culto, del
full frontal cumshot girato alla fine del primo giorno
di riprese, con tanto di richiesta esplicita di Karl Glusman a Noé di
togliersi dal suo campo visivo per non inibire l'eiaculazione).

Attenzione
però a non scambiare Murphy per l’alter ego di Gaspar Noé: la svista
più imperdonabile che si potrebbe commettere (stortura che si è
puntualmente verificata) nei confronti di
Love
consisterebbe proprio nel confondere il punto di vista di Murphy con
quello del film nel suo complesso e di lì (il passo è breve) con quello
di Noé stesso. Nonostante porti il cognome materno del regista, ne
indossi le magliette e la giacca militare
à la Travis Bickle e
benché le pareti della sua camera siano tappezzate di poster e
suppellettili di proprietà del cineasta (tra i quali spicca il modellino
del LOVE HOTEL già utilizzato in
Enter the Void),
Murphy appartiene a pieno titolo alla stirpe dei protagonisti
sgradevoli, inconcludenti e caricaturali ai quali Noé ci ha abituati fin
dal suo esordio (
GN:
“My characters are never heroic. They are mostly lost and trying to
find the right door to open and they end up opening the wrong doors”).
Come il boucher interpretato da Philippe Nahon in
Carne (1991) e
Seul contre tous
(1998), Murphy è il tipico antieroe di Noé in cui si accumulano
velenosamente aspirazioni velleitarie (si dichiara un filmmaker ma le
sue pompose ambizioni non trovano alcun riscontro effettivo),
atteggiamenti stereotipati (propina indistintamente le stesse formule
sentimentali all’ex fidanzata Lucile e a Electra, spingendosi
addirittura a suggerire lo stesso nome per il figlio prima a Electra e,
nell’inquadratura immediatamente successiva, a Omi/Klara Kristin) e
maschilismo tracotante (l’aggressione al gallerista insolentemente
interpretato dallo stesso Noé con parrucca petersellersiana,
l’interrogatorio in centrale col poliziotto interpretato in modo
formidabile daVincent Maraval al suo esordio nei panni di un flic
lussurioso).

Il profondo legame tra il cialtronesco protagonista di
Love, il macellaio xenofobo di
Carne/
Seul contre tous e il giovane Oscar di
Enter the Void
si oggettiva inoltre nel risentito vittimismo della voce over, permeata
di un’acredine e di un’autocommiserazione che, pur ammantate di
nostalgica rassegnazione, richiamano esplicitamente le rancorose
recriminazioni del boucher nei confronti della ributtante compagna
(boucher: “Un salame di merda. Un vino di merda e una famiglia di merda
in un paese di merda”; Oscar: “Ne ho abbastanza di questa puttana (…)
Vivere con una donna è come condividere il letto con la CIA”) e la
tossica autoindulgenza dell’inconsapevole morituro di
Enter the Void
(Oscar, poco prima di accendersi una pipa di DMT, bisbiglia
paradossalmente: “I know I’m not a junkie”; Murphy, sotto oppio, mormora
tra sé e sé: “I feel like a junkie”). Quelli di Noé, insomma, sono
sempre protagonisti che, nonostante l’impronta soggettiva impressa ai
film, ingaggiano lo spettatore in una dinamica giocata sul filo
dell’identificazione e della repulsione: se gli smacchi che vivono
incoraggiano fortemente l’immedesimazione, le loro meschinità e i loro
egoismi ostacolano altrettanto fortemente l’adesione incondizionata.
Sollecitato e intralciato al tempo stesso, lo spettatore è dunque preso
in un’impasse che neutralizza i convenzionali e rassicuranti meccanismi
di partecipazione emotiva. Messo fuori causa l’apparato psicologico, il
cinema di Noé è dunque libero di sferrare l’offensiva sul fronte
sensoriale e pulsionale della rappresentazione cinematografica (“I miei
film parlano delle pulsioni mammifere - o rettili - dell’uomo e della
donna”). E benché
Love non costituisca il capo d’opera
del cineasta franco-argentino (alcuni stilemi come le didascalie a tutto
schermo e gli stacchi in nero “effetto diaporama” sono qui adoperati in
chiave vezzosamente ornamentale), l’ultimo film di Gaspar Noé
rappresenta l’ennesima testimonianza di un talento espressivo capace di
lasciare un segno indelebile nel panorama internazionale con
proposizioni cinematografiche di profonda originalità e inesausta
radicalità. Uno dei rari casi in cui la cinefilia non fagocita
l’inventiva e la vitalità nelle soffocanti spire del miserabile
metacinema.
Questo, tra tutti i miei film, è quello più vicino a ciò che ho potuto conoscere dell’esistenza e anche il più malinconico.
Un ringraziamento a Lorenzo Baldassari per la consulenza tecnica.
 “La storia dell’edificio simbolo di Milano, a partire dalla notte in cui
Gian Galeazzo Visconti sognò il diavolo che gli intimava di costruire
un luogo maestoso. La sua risposta fu immediata: concedere l’uso delle
cave di Candoglia a una Veneranda Fabbrica per costruire una cattedrale
degna dei sogni di grandezza della casata. Dalla fine del ’300 ai primi
anni del ’900, quando l’ultima porta di bronzo venne posizionata, dalle
cave sono partiti in barca più di mezzo milione di blocchi di marmo. I
due cineasti ci conducono attraverso i secoli in quello che appare un
lavoro in continuo divenire. Primo atto della quadrilogia Spira
Mirabilis sul concetto di immortalità attraverso gli elementi della
natura, L’infinita fabbrica del Duomo rappresenta la Terra. I testi adattati da Milano in mano di Guido Lopez e Silvestro Severgnini e Storia della Veneranda fabbrica
di Carlo Ferrari da Passano rappresentano un contrappunto al racconto
per immagini e alla riflessione su finitezza e immortalità” (dalla
scheda del FilmMakerFest 2015).
“La storia dell’edificio simbolo di Milano, a partire dalla notte in cui
Gian Galeazzo Visconti sognò il diavolo che gli intimava di costruire
un luogo maestoso. La sua risposta fu immediata: concedere l’uso delle
cave di Candoglia a una Veneranda Fabbrica per costruire una cattedrale
degna dei sogni di grandezza della casata. Dalla fine del ’300 ai primi
anni del ’900, quando l’ultima porta di bronzo venne posizionata, dalle
cave sono partiti in barca più di mezzo milione di blocchi di marmo. I
due cineasti ci conducono attraverso i secoli in quello che appare un
lavoro in continuo divenire. Primo atto della quadrilogia Spira
Mirabilis sul concetto di immortalità attraverso gli elementi della
natura, L’infinita fabbrica del Duomo rappresenta la Terra. I testi adattati da Milano in mano di Guido Lopez e Silvestro Severgnini e Storia della Veneranda fabbrica
di Carlo Ferrari da Passano rappresentano un contrappunto al racconto
per immagini e alla riflessione su finitezza e immortalità” (dalla
scheda del FilmMakerFest 2015).  Le inquadrature iniziali de L’infinita Fabbrica del Duomo, primo pannello di una tetralogia sugli elementi naturali intitolata Spira Mirabilis,
sono dedicate all’olmo più antico d’Italia, piantato nel 1386 ai piedi
della montagna dalla quale, nello stesso anno, si estraeva il primo
blocco di marmo per la costruzione della cattedrale. Scrutato dal nodoso
interno della sua cavità e osservato nelle sue poderose ramificazioni
sorrette da stampelle, l’olmo di Mergozzo si collega alla vicenda del
Duomo non soltanto per concomitanza cronologica e geografica, ma
soprattutto per tradizione leggendaria, poiché, come recita la
didascalia che chiude il prologo: “La leggenda dice che finché l’olmo
vivrà, anche la cattedrale rimarrà in piedi”. È precisamente questa la
traiettoria dell’ultimo lavoro di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi:
ricavare dagli elementi (in questo caso la terra) un dialogo organico
che, pur non smarrendo il punto focale di osservazione, restituisca la
loro incessante compenetrazione, la loro continua sovrapposizione. Ed è
così che procede L’infinita Fabbrica del Duomo: con un
movimento ascensionale che dalle viscere delle montagne di Candoglia
conduce alla sommità della cattedrale e al cielo che si staglia dietro
le statue svettanti sulle guglie. Dalla terra all’aria, dall’elemento
terrestre a quello celeste passando per l’infinito lavorio degli uomini,
soprattutto quelli umili, anonimi e dimenticati.
Le inquadrature iniziali de L’infinita Fabbrica del Duomo, primo pannello di una tetralogia sugli elementi naturali intitolata Spira Mirabilis,
sono dedicate all’olmo più antico d’Italia, piantato nel 1386 ai piedi
della montagna dalla quale, nello stesso anno, si estraeva il primo
blocco di marmo per la costruzione della cattedrale. Scrutato dal nodoso
interno della sua cavità e osservato nelle sue poderose ramificazioni
sorrette da stampelle, l’olmo di Mergozzo si collega alla vicenda del
Duomo non soltanto per concomitanza cronologica e geografica, ma
soprattutto per tradizione leggendaria, poiché, come recita la
didascalia che chiude il prologo: “La leggenda dice che finché l’olmo
vivrà, anche la cattedrale rimarrà in piedi”. È precisamente questa la
traiettoria dell’ultimo lavoro di Martina Parenti e Massimo D’Anolfi:
ricavare dagli elementi (in questo caso la terra) un dialogo organico
che, pur non smarrendo il punto focale di osservazione, restituisca la
loro incessante compenetrazione, la loro continua sovrapposizione. Ed è
così che procede L’infinita Fabbrica del Duomo: con un
movimento ascensionale che dalle viscere delle montagne di Candoglia
conduce alla sommità della cattedrale e al cielo che si staglia dietro
le statue svettanti sulle guglie. Dalla terra all’aria, dall’elemento
terrestre a quello celeste passando per l’infinito lavorio degli uomini,
soprattutto quelli umili, anonimi e dimenticati. Autentica
chiave di volta del titolo, l’aggettivo “infinita” esprime insieme
grandezza e miseria: grandezza di un’opera che, per ambizione e sfarzo,
tende alla “gloria di colui che tutto move” e miseria di un lavoro che,
per glorificare il divino, implica privazioni e violenza. Privazioni di
chi, lavorando nell’ombra e sacrificando le proprie risorse alla
Veneranda Fabbrica, ha contribuito all’edificazione e alla manutenzione
della maestosa cattedrale; violenza praticata da secoli sugli elementi
per creare un gigantesco simbolo del dominio sul creato: “Nel caso del
Duomo abbiamo trovato interessante l’idea che sia stato realizzato con
le più alte intenzioni, ma a partire comunque da un atto di violenza nei
confronti della natura. L’estrazione del marmo, della materia prima
dalla montagna è un gesto violento: il taglio di queste vene marmoree è
il primo segno di una perdita di innocenza. L’opera dell’uomo ha sempre e
comunque a che fare con qualcosa di brutale” (Massimo D’Anolfi).
Una violenza, dunque, che, pur animata da intenti solennemente
celebrativi e apotropaici (la terza didascalia recita: “Tutto cominciò
la notte in cui Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, sognò il
diavolo in persona che gli intimava di costruire un luogo maestoso e
ricco di immagini sataniche e demoniache. Pena le fiamme dell’inferno”),
è intrinsecamente e inevitabilmente connessa all’azione umana, al suo
intervento diretto sugli elementi naturali. Edificare un tempio alla
gloria celeste significa contemporaneamente sventrare montagne, alterare
la fisionomia del territorio, operare un intervento sul corpo della
natura (alcune immagini in negativo e alcune immagini d’archivio delle
cave di Candoglia sono piazzate davanti ai nostri occhi e sfogliate
clinicamente come radiografie).
Autentica
chiave di volta del titolo, l’aggettivo “infinita” esprime insieme
grandezza e miseria: grandezza di un’opera che, per ambizione e sfarzo,
tende alla “gloria di colui che tutto move” e miseria di un lavoro che,
per glorificare il divino, implica privazioni e violenza. Privazioni di
chi, lavorando nell’ombra e sacrificando le proprie risorse alla
Veneranda Fabbrica, ha contribuito all’edificazione e alla manutenzione
della maestosa cattedrale; violenza praticata da secoli sugli elementi
per creare un gigantesco simbolo del dominio sul creato: “Nel caso del
Duomo abbiamo trovato interessante l’idea che sia stato realizzato con
le più alte intenzioni, ma a partire comunque da un atto di violenza nei
confronti della natura. L’estrazione del marmo, della materia prima
dalla montagna è un gesto violento: il taglio di queste vene marmoree è
il primo segno di una perdita di innocenza. L’opera dell’uomo ha sempre e
comunque a che fare con qualcosa di brutale” (Massimo D’Anolfi).
Una violenza, dunque, che, pur animata da intenti solennemente
celebrativi e apotropaici (la terza didascalia recita: “Tutto cominciò
la notte in cui Gian Galeazzo Visconti, signore di Milano, sognò il
diavolo in persona che gli intimava di costruire un luogo maestoso e
ricco di immagini sataniche e demoniache. Pena le fiamme dell’inferno”),
è intrinsecamente e inevitabilmente connessa all’azione umana, al suo
intervento diretto sugli elementi naturali. Edificare un tempio alla
gloria celeste significa contemporaneamente sventrare montagne, alterare
la fisionomia del territorio, operare un intervento sul corpo della
natura (alcune immagini in negativo e alcune immagini d’archivio delle
cave di Candoglia sono piazzate davanti ai nostri occhi e sfogliate
clinicamente come radiografie). Eppure
a imporsi, agli occhi di chi scrive, è soprattutto l’indocilità della
materia, la sua resistenza ai tagli inferti dall’uomo. Una riluttanza
che s’indovina, non troppo diversamente da ciò che accadeva con
l’umanità residuale di Materia oscura o Il castello,
nei detriti inutilizzabili, nelle fragorose cascate di pietrisco, nella
consunzione che sfigura i volti e abrade le forme delle statue, in una
lucertola che fa capolino dalla cavità di un frammento lapideo dismesso,
nel candido pulviscolo che imbianca le officine dei cantieri. È qui che
la materia prende la sua rivincita, ribellandosi alla proterva
brutalità dell’opera umana, negando il segno netto e incisivo impresso
dal lavoro dell’uomo. Sotto l’apparente celebrazione della solerte e
inesausta laboriosità umana (la Fabbrica del Duomo è Veneranda per
definizione: degna di rispetto e ammirazione) si disegna quindi un’altra
storia, quella del perenne antagonismo tra uomo e ambiente, tra azione
umana e materia prima: è questo l’autentico fulcro del cinema di Martina
Parenti e Massimo D’Anolfi (ancora D’Anolfi: “In Materia oscura siamo davanti a una brutalità stupida e ottusa, mentre in L’infinita fabbrica
è quasi connaturata all’azione umana nel momento in cui si rapporta con
la natura; c’è sempre una sorta di sentimento di appropriazione, anche
quando si vogliono fare cose buone”). Insomma, più vedo i loro film e
più mi convinco che siano l’antagonismo e la residualità a costituire il
nucleo del loro fare cinema: la tenace umanità interstiziale de Il castello o di Materia oscura resiste alla violenza del potere così come la marmorea materialità de L’infinita Fabbrica del Duomo resiste alla superbia della significazione umana (significare nel senso di “signum facere”: fabbricare appositamente un segno).
Eppure
a imporsi, agli occhi di chi scrive, è soprattutto l’indocilità della
materia, la sua resistenza ai tagli inferti dall’uomo. Una riluttanza
che s’indovina, non troppo diversamente da ciò che accadeva con
l’umanità residuale di Materia oscura o Il castello,
nei detriti inutilizzabili, nelle fragorose cascate di pietrisco, nella
consunzione che sfigura i volti e abrade le forme delle statue, in una
lucertola che fa capolino dalla cavità di un frammento lapideo dismesso,
nel candido pulviscolo che imbianca le officine dei cantieri. È qui che
la materia prende la sua rivincita, ribellandosi alla proterva
brutalità dell’opera umana, negando il segno netto e incisivo impresso
dal lavoro dell’uomo. Sotto l’apparente celebrazione della solerte e
inesausta laboriosità umana (la Fabbrica del Duomo è Veneranda per
definizione: degna di rispetto e ammirazione) si disegna quindi un’altra
storia, quella del perenne antagonismo tra uomo e ambiente, tra azione
umana e materia prima: è questo l’autentico fulcro del cinema di Martina
Parenti e Massimo D’Anolfi (ancora D’Anolfi: “In Materia oscura siamo davanti a una brutalità stupida e ottusa, mentre in L’infinita fabbrica
è quasi connaturata all’azione umana nel momento in cui si rapporta con
la natura; c’è sempre una sorta di sentimento di appropriazione, anche
quando si vogliono fare cose buone”). Insomma, più vedo i loro film e
più mi convinco che siano l’antagonismo e la residualità a costituire il
nucleo del loro fare cinema: la tenace umanità interstiziale de Il castello o di Materia oscura resiste alla violenza del potere così come la marmorea materialità de L’infinita Fabbrica del Duomo resiste alla superbia della significazione umana (significare nel senso di “signum facere”: fabbricare appositamente un segno). Così,
alla storia ufficiale del Duomo, raffigurato apertamente come un
gigantesco organismo che possiede i propri ritmi, i propri rumori e le
proprie funzioni quasi fisiologiche (si presti attenzione allo
sgocciolamento della cera, raccolta quotidianamente alla stregua di
deiezioni animali), si contrappone la storia segreta di questa
indocilità della materia segnata dallo scarto, dal deperimento, dalla
caducità (le sculture e i frammenti lapidei eccessivamente corrosi
vengono accantonati nel cimitero delle statue). Scandito da ventisette
didascalie ricavate dai documenti custoditi nell’archivio della Fabbrica
e cadenzato dal metronomo di un montaggio che genera una musicalità
visiva pullulante di ritmi interni, L’infinita Fabbrica del Duomo
si sviluppa in quattro movimenti ascendenti intrecciati tra loro (le
cave, l’archivio, il cantiere e la cattedrale), lasciando che il motivo
cimiteriale s’insinui lieve tra una sezione e l’altra come un Leitmotiv
(o meglio una Totentanz) sommessamente dissacrante - una sorta di
disadorna vanitas che contrasta la monumentale grandiosità
dell’opera, riportando in terra l’anelito celeste. Ricondurre la
sfrenata ambizione umana alla concretezza minerale della natura, la
maestosità della cattedrale alla dimensione originaria della conchiglia,
come chiarisce definitivamente la penultima didascalia: “Sicché,
scolpito in questo grandioso monumento, noi vediamo il racconto di tante
generazioni, ma anche il segno profondo della natura che impiega 10.000
anni per trasformare un deposito di conchiglie in una vena di marmo
rosa. Il Duomo è cresciuto da una conchiglia, le conchiglie sono
cattedrali”. Il segreto del cinema di Martina Parenti e Massimo
D’Anolfi? Immagini che racchiudono il mondo senza rinchiuderlo
nell’angusta cornice di un quadro.
Così,
alla storia ufficiale del Duomo, raffigurato apertamente come un
gigantesco organismo che possiede i propri ritmi, i propri rumori e le
proprie funzioni quasi fisiologiche (si presti attenzione allo
sgocciolamento della cera, raccolta quotidianamente alla stregua di
deiezioni animali), si contrappone la storia segreta di questa
indocilità della materia segnata dallo scarto, dal deperimento, dalla
caducità (le sculture e i frammenti lapidei eccessivamente corrosi
vengono accantonati nel cimitero delle statue). Scandito da ventisette
didascalie ricavate dai documenti custoditi nell’archivio della Fabbrica
e cadenzato dal metronomo di un montaggio che genera una musicalità
visiva pullulante di ritmi interni, L’infinita Fabbrica del Duomo
si sviluppa in quattro movimenti ascendenti intrecciati tra loro (le
cave, l’archivio, il cantiere e la cattedrale), lasciando che il motivo
cimiteriale s’insinui lieve tra una sezione e l’altra come un Leitmotiv
(o meglio una Totentanz) sommessamente dissacrante - una sorta di
disadorna vanitas che contrasta la monumentale grandiosità
dell’opera, riportando in terra l’anelito celeste. Ricondurre la
sfrenata ambizione umana alla concretezza minerale della natura, la
maestosità della cattedrale alla dimensione originaria della conchiglia,
come chiarisce definitivamente la penultima didascalia: “Sicché,
scolpito in questo grandioso monumento, noi vediamo il racconto di tante
generazioni, ma anche il segno profondo della natura che impiega 10.000
anni per trasformare un deposito di conchiglie in una vena di marmo
rosa. Il Duomo è cresciuto da una conchiglia, le conchiglie sono
cattedrali”. Il segreto del cinema di Martina Parenti e Massimo
D’Anolfi? Immagini che racchiudono il mondo senza rinchiuderlo
nell’angusta cornice di un quadro.