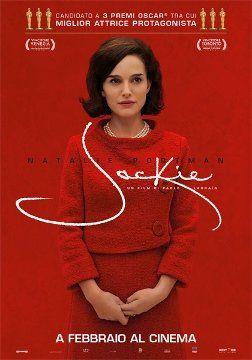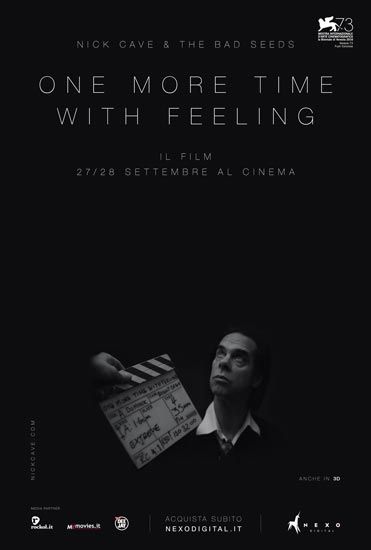Al termine della Prima guerra mondiale, in una cittadina tedesca, Anna
si reca tutti i giorni sulla tomba del fidanzato Frantz, morto al fronte
in Francia. Un giorno incontra Adrien, un giovane francese anche lui
andato a raccogliersi sulla tomba dell'amico tedesco. La presenza dello
straniero nella cittadina tedesca susciterà reazioni sociali molto forti
e sentimenti estremi (dal pressbook).
Presentato in concorso alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.
Premio Marcello Mastroianni a Paula Beer per la miglior attrice emergente.
Distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 22 settembre 2016.
I - Premessa autoreferenziale: il principio vitale della metamorfosi

Nel secondo numero di
INLAND. Quaderni di cinema,
ho tentato di individuare ciò che, semplificando quel tanto che basta a
rappresentarsi le cose, ho definito l'"elemento ozoniano", vale a dire
quell'elemento capace di assumere la posizione di fulcro nell'intero
cinema di François Ozon, assicurando all'insieme dei suoi film
un'organizzazione dinamica e singolare. Mi permetto di rimandare
spudoratamente al contributo di INLAND poiché lì passo in rassegna la
sua intera filmografia alla luce di questo ipotetico elemento
fondamentale (cosa che mi asterrò scrupolosamente dal fare in questa
sede). Mette comunque conto riportare sinteticamente l'ipotesi formulata
in quel breve saggio, perché di fatto è la stessa che orienta le
seguenti riflessioni. In
La pelle e la traccia: riscritture del sé. Il cinema trasformazionale di François Ozon
ipotizzo dunque che questo fatidico elemento risieda nell'esigenza di
cambiare continuamente pelle, mantenendo come traccia permanente la
riscrittura dell'identità: "Non una variazione sul tema identitario
condotta con sguardo immutabile, ma una dialettica che impegna e investe
lo statuto dello stesso sguardo: l'epidermide muta di pellicola in
pellicola, la traccia persiste nella metamorfosi stessa". Nel cinema di
Ozon, insomma, ogni pellicola (alla lettera "piccola pelle") non farebbe
che ripeterci questo: l'identità resta florida solo a condizione di
mutare, il suo nucleo vitale non coincidendo affatto con l'unità
definitiva e difensiva ma, al contrario, con la trasformazione
permanente. Questo, in estrema sintesi, quello che ritengo essere
l'elemento specifico, originario e semplicemente irrinunciabile del suo
cinema, elemento che a mio avviso trova compiuta incarnazione in
Ricky,
infante alato nel quale convergono, facendo e facendosi corpo, i tratti
di un'identità rigogliosa poiché libera di dispiegare le marche della
differenza e quelli di un cinema che della metamorfosi ha fatto un vero e
proprio principio vitale.

Osservato
da questa angolazione, il radicale del cinema di Ozon coinciderebbe
quindi con la mutazione pellicolare e, al tempo stesso, con l'identità
come trasformazione, movimento continuo, plasticità dinamica. Ovviamente
non si tratta del cencioso concetto di adattamento (il che
trascinerebbe l'intero discorso sul versante del conformismo), ma, più
precisamente, della necessità di non lasciarsi intrappolare dal
protocollo affettivo ricevuto e assumere soggettivamente, riscrivendolo,
il destino già programmato per ciascun individuo dal complesso di norme
e istituzioni sociali (la famiglia in primo luogo). Tuttavia, lo
ripeto, questo movimento non interessa soltanto i personaggi messi in
scena di film in film, ma coinvolge lo stesso dispositivo
cinematografico di Ozon, sottoponendolo a torsioni, deformazioni e
riconfigurazioni ininterrotte (è una cosa che Melvil Poupaud ha detto
con invidiabile essenzialità: "Gira molto e cambia stile ogni volta,
restando personale al tempo stesso"). Questa esigenza trasformazionale è
così irrinunciabile da aver portato Ozon a concepire persino il
"film-mix"
Quand la peur dévore l'âme (2007), ibrido intertestuale creato con la libera combinazione di parti di
Secondo amore (Douglas Sirk, 1955) e
La paura mangia l'anima
(Rainer Werner Fassbinder, 1974). Mi pare assolutamente evidente che
questo mediometraggio inveri formalmente il principio vitale della
poetica ozoniana: plasmare nuove identità a partire dalla
riconfigurazione di quelle ereditate.
II - Spostamento del punto di vista: condividere l'inconsapevolezza

Ebbene, questo movimento di riappropriazione e soggettivazione è esattamente quello che permea
Frantz, film liberamente ispirato a
L'uomo che ho ucciso (
Broken Lullaby, 1932) di Ernst Lubitsch - pellicola a sua volta basata sulla pièce teatrale
L'Homme que j’ai tué di Maurice Rostand. Il rapporto coi lavori di Rostand e Lubitsch è molto simile a quello che contraddistingue
Quand la peur dévore l'âme:
pièce e pellicola vengono assunti come testi da rispettare
esteriormente e riscrivere intimamente. Ne scaturisce una sorta di
palinsesto che si nutre delle raschiature e delle interpolazioni imposte
soggettivamente alla materia di partenza. La ripresa soggettiva di
Broken Lullaby
si compie infatti all'insegna di uno stravolgimento plateale: il
ribaltamento del punto di vista dominante. Se il lavoro teatrale di
Rostand e la pellicola di Lubitsch sposavano il punto di vista del
protagonista maschile, Ozon sposta il baricentro emotivo e cognitivo
sullo sguardo della fidanzata del soldato tedesco ucciso in trincea. Lo
spostamento del punto di vista induce una profonda riconfigurazione
della materia di partenza, poiché, pur mantenendo la tela narrativa di
fondo (ambientazione storica e dinamiche drammaturgiche di base),
l'adozione del nuovo angolo visuale comporta un posizionamento dello
spettatore radicalmente differente: non più una posizione onnisciente e
trepidante per il senso di colpa provato dal giovane francese che si
reca in Germania per piatire il perdono, ma una condizione di
inconsapevolezza e curiosità condivisa con la protagonista femminile che
ha perso il fidanzato in guerra. In termini narratologici, ci troviamo
in una situazione di focalizzazione interna, ovvero sappiamo soltanto
ciò che sa Anna (Paula Beer) e ogni sua acquisizione cognitiva coincide
con un nostro passo in avanti verso la scoperta della verità. Il
desiderio di Ozon, come espresso dalle dichiarazioni contenute nel
pressbook, si concentra fondamentalmente su questo nuovo orientamento
narrativo: "il film di Lubitsch (…) è molto simile allo spettacolo
teatrale e adotta lo stesso punto di vista, quello del giovane francese.
Il mio desiderio invece era di adottare il punto di vista della ragazza
che, così come lo spettatore, non sa perché quel giovane francese si
reca sulla tomba del suo fidanzato".

È
fin troppo semplice rilevare come questa dislocazione del punto di
vista scateni l'attività congetturale dello spettatore. Detto più
semplicemente, lo spettatore, privato dell’onniscienza di cui godeva
nella pièce di Rostand e nella pellicola di Lubitsch, si trova costretto
a formulare ipotesi sulla reale identità di Adrien (Pierre Niney) e
sulla relazione che questo sconosciuto aveva con Frantz (Anton von
Lucke). Chi è questo giovane francese spuntato dal nulla? Quale rapporto
lo lega a Frantz? Perché è così ossessionato dalla memoria del defunto?
Tutte queste domande non hanno luogo in
Broken Lullaby,
dal momento che lo spettatore sa fin dall'inizio che Paul (questo il
nome del soldato francese nel film di Lubitsch) ha ucciso l'imbelle
Walter in trincea (donde l'eloquente titolo
L'uomo che ho ucciso). Insomma, in
Frantz
non è più la colpevolezza del soldato francese a menare le danze e
costituire il nucleo emotivo della vicenda, ma l'inconsapevolezza
equamente condivisa tra Anna e lo spettatore. Ed è proprio questa
condizione d'inconsapevolezza condivisa a creare i presupposti di quella
metamorfosi identitaria che, come abbiamo visto, costituisce il
principio vitale del cinema di Ozon: è solo sulla base di questa
incertezza che può svilupparsi la disponibilità all'apertura e alla
trasformazione soggettiva. In palio c'è qualcosa di molto più cruciale
del semplice intrattenimento: lo spostamento del punto di vista non
risponde soltanto all'accrescimento del mistero intrigante, ma,
soprattutto, all'allestimento di un teatro interiore propizio al
dispiegamento della metamorfosi. Una metamorfosi che, naturalmente,
investirà in primo luogo l'identità della protagonista, ma che, grazie
alla centralità del suo punto di vista, coinvolgerà indirettamente e
provvisoriamente (quanto meno per la durata della visione) anche quella
dello spettatore.
III - Il movimento come materializzazione del percorso di trasformazione

È il movimento, in effetti, a rappresentare l'aspetto più appariscente di
Frantz,
un movimento che dapprima interessa la sola Anna, ma che, per
interposta protagonista, finisce per contagiare lo spettatore: nel
movimento del personaggio vediamo materializzarsi il suo stato e le sue
potenzialità dinamiche, immedesimandoci nel suo percorso fisico e
psicologico. Non è affatto fortuito che il film si apra sulla camminata
della ritrosa Anna per le strade, i vicoli e le scalinate (elemento
dinamico tutt'altro che secondario nel cinema di Ozon, basti pensare
alla rilevanza scenografica della scala in
8 donne e un mistero)
della cittadina tedesca di Quedlinburg. In questo silenzioso e
solitario tragitto, non a caso completamente assente nel film di
Lubistch in cui una dissolvenza incrociata elide classicamente il
percorso dal negozio di fiori al cimitero, ci mettiamo in cammino
insieme al personaggio, osservando il suo disinteresse per gli uomini
che la guardano, interrogandoci sulla sua condizione, ipotizzando gli
sviluppi futuri della vicenda. È del resto lo stesso Ozon a sottolineare
l'importanza di questo incipit itinerante: "Mi piace molto riprendere i
tragitti percorsi, è un modo concreto di materializzare l'idea del
movimento dei personaggi e di mettere il film e i protagonisti in un
luogo geografico. Era importante mostrare quella cittadina tedesca, quei
tragitti dalla casa al cimitero, e poi fino alla Gasthaus. Guardare
quel tragitto è interrogarsi sul personaggio, capire il suo percorso.
All’inizio Anna è un po' ferma, gira su se stessa in questa cittadina.
Per poi affrontare il grande viaggio che la porterà in Francia e la farà
andare oltre le apparenze".

Ed è un indizio altrettanto rivelatorio il fatto che l'epilogo di
Frantz
sia scandito da un'altra camminata della protagonista, ma di senso
diametralmente opposto a quello luttuoso e rassegnato dell'incipit:
stavolta siamo al Louvre e Anna, di nuovo
Giovane e bella (è stata la madre, spronandola a partire per Parigi, a sussurrarle
"sei giovane e bella, non perdere questa chance!"),
percorre i corridoi del museo con passo sicuro e spregiudicato,
finalmente consapevole e disponibile all'incontro con l'altro (il
dialogo conclusivo davanti al quadro di Manet ha quasi il sapore di un
abbordaggio). Tuttavia non si tratta soltanto di emancipazione
femminile, ma, più ampiamente, di trasformazione sentimentale, apertura
all'esistenza. Ancora Ozon: “La sceneggiatura del film è costruita come
un Bildungsroman, come un romanzo di formazione. Non ci conduce in un
mondo di sogni o di evasione ma segue l'educazione sentimentale di Anna,
le sue disillusioni riguardo alla realtà, alla bugia, al desiderio,
alla maniera di un racconto iniziatico". Tra l'incipit chiuso nel dolore
funereo e il finale aperto alla voglia di vivere ("Il me donne envie de
vivre", dice Anna guardando il dipinto
Le Suicidé) c'è
l'incontro con Adrien, palese doppio di Frantz, c'è l'azione
consolatoria della menzogna da lui avallata e, soprattutto, c'è la
diversa piega che l'elaborazione del lutto prende per i due
protagonisti. Momentaneamente ravvivato dalle bugie di Adrien, il
romanticismo di Anna viene soffocato dalla scoperta della verità (le
colorite passeggiate nella natura, ispirate alla pittura romantica di
Caspar David Friedrich, perdono all'improvviso ogni umore cromatico). E
se Adrien si rifugia vigliaccamente nell'abbraccio letale della
famiglia, Anna non si lascia abbattere dalle disillusioni incassate a
ripetizione, trovando al contrario, nell'acquiescenza del giovane
francese, uno stimolo a cercare la propria indipendenza al di fuori
della confortevole e mortale cornice domestica. Detto altrimenti, Adrien
sopravvive fisicamente alla guerra in trincea e muore sentimentalmente
tra le quattro mura della sua lussuosa dimora (il matrimonio programmato
dalla madre con Fanny/Alice de Lencquesaing); mentre Anna, tentato il
suicidio nelle fredde acque di un lago sassone per la disperazione,
rinasce a nuova vita proprio dopo aver assaporato fino in fondo il
veleno delle costrizioni familiari e averne osservato gli irreversibili
effetti su Adrien (l'ultimo dialogo con la di lui perfida madre/Cyrielle
Clair).
IV - Metamorfosi e suicidio: cambiare o morire

Tutto ciò ci riconduce, a posteriori, al principio della metamorfosi. Mi pare difatti che
Frantz, analogamente e antiteticamente a
Il tempo che resta,
porti alle estreme conseguenze il discorso della trasformazione come
questione di vita o di morte. Se il film del 2005 ci mostrava che
persino la morte imminente poteva rappresentare un'occasione di apertura
al cambiamento (il titolo del film fa pensare non solo al tempo che
resta da vivere nella vita di un uomo, ma anche al tempo che rimane
davvero della sua vita),
Frantz ci mostra che l'ombra
della morte può cadere sul soggetto in vita, perfettamente sano e con
molti anni davanti a lui. In altri termini, se
Il tempo che resta mostrava l'apertura alla vita perfino nella morte annunciata,
Frantz mostra inversamente la chiusura mortale nella vita agiata. Con
Frantz,
insomma, ci troviamo di fronte alla formulazione definitiva delle
conseguenze derivanti dall'incapacità di trasformarsi, dalla riluttanza
nell'abbracciare il percorso della metamorfosi: rinunciare alla
trasformazione equivale a una condanna a morte, al suicidio o alla morte
in vita (che, in fondo, è esattamente la stessa cosa). E sono proprio i
due tentati suicidi di
Frantz a suggerire
cinematograficamente questa equivalenza: nel momento in cui le
possibilità di cambiamento appaiono sbarrate (Anna ha scoperto la
menzogna di Adrien; Adrien è tornato in Francia con la coda tra le
gambe), entrambi i personaggi provano a farla finita. Ma se Anna viene
salvata dall'inopinato soccorso di un passante e, nonostante l'amarezza
del disincanto, ritrova lentamente il desiderio di vivere (i genitori di
Frantz e il confessore in questo senso favoriscono il suo recupero),
Adrien, benché scampato al tentato suicidio, muore virtualmente
rinunciando a spezzare la lapidaria linea familiare (quello di Adrien è
fin troppo emblematicamente un destino di morte, le sue iniziali incise
sulla tomba dello zio colonnello sanciscono per metonimia che il suo
slancio vitale è ormai morto e sepolto). Non è pertanto fortuito che sia
il solo tentato suicidio di Anna a essere rappresentato integralmente,
mentre quello di Adrien è ricostruito per via indiziaria attraverso
consultazioni di medici, registri clinici e, infine, testimonianze dello
stesso giovane. È proprio questa mancata rappresentazione, che
ovviamente non risponde a esigenze di sintesi (una breve scena dell'atto
avrebbe occupato molto meno tempo della lunga e fuorviante indagine di
Anna), a segnalarne tutto il peso specifico: affidando alla ragazza
tedesca il ruolo attivo e ostinato di detective, il film allude al fatto
che Adrien sia ormai un residuo passivo, un morto vivente sepolto in
una tomba non meno marmorea di quella in cui è tumulato lo zio, il
castello di famiglia. Nella ricerca dello scomparso Adrien (non suona
più nell'orchestra, non è più ricoverato nella clinica psichiatrica, non
è più a Parigi), Anna non ha fatto che passare da una tomba all'altra,
da un sepolcro all'altro. E se lei continua a muoversi e cambiare,
Adrien, ormai condannato a deperire comodamente, ha letteralmente smesso
di farlo: "È troppo tardi", gli dice piangendo e dandogli un bacio in
extremis mentre il suo treno per Parigi è sul punto di partire.

Azione
castrante della madre di Adrien e morte in vita di quest'ultimo,
funzione emancipatoria dei genitori di Frantz e del confessore e,
infine, movimento/mutamento liberatorio di Anna: il quadro d'insieme
sembrerebbe completo. Ma di fatto manca un dettaglio fondamentale:
perché il film s'intitola
Frantz anziché "Anna", "Anna e
Adrien" e via ipotizzando? Quale posizione occupa il giovane tedesco
ucciso ancor prima dell'inizio del film? In primo luogo, il suo ruolo di
assente onnipresente non è troppo dissimile da quello rivestito dalle
figure maschili nella celebre commedia
Donne (
The Women,
1939) di George Cukor: pur essendo rigorosamente esclusi dalla scena
tutta al femminile, gli uomini sono i protagonisti assoluti dei dialoghi
e delle dinamiche rappresentate. In virtù della sua assenza fisica,
insomma, Frantz acquisisce una presenza drammaturgica così ingombrante
da farsi chiodo fisso, ossessione inestirpabile: la replica di Anna alla
madre di Adrien al termine del dialogo di congedo -
"Non sono io che tormento suo figlio, signora, è Frantz"
- esplicita definitivamente l'onnipresenza di questo fantasma
aleggiante su tutto il film. In secondo luogo, di gran lunga più
decisivo del primo, Frantz riassume esemplarmente in sé i tratti
dell'auctor in fabula, non soltanto rivestendo il ruolo di doppio
fantomatico di Adrien (col violino a fare da sonante oggetto mediatore
tra i due), ma, soprattutto, assumendo a pieno titolo la funzione
registica. Detto in termini più brutali, Frantz rappresenta lo stesso
Ozon all'interno del film. Non è solo l'ovvia concatenazione lessicale
"Frantz>Französisch>Français>François" a suggerire questa
assimilazione, ma, meno banalmente, il suo agire nell'ombra e il suo
palesarsi nel riflesso di Adrien. Che cosa fa Frantz oltre a morire in
trincea e ossessionare i personaggi con la sua assenza? Scrive una
lettera che funziona come una sceneggiatura, elegge Adrien a suo
sostituto in una sorta di casting suicida e, dettaglio letteralmente
determinante, vigila sornione sull'intera vicenda. È lui che, in
albergo, occhieggia dall'altra parte dello specchio stabilendo una
complice intesa con Adrien, complicità che suona distintamente come
un'investitura ufficiale. È il suo sguardo a oggettivarsi virtualmente
nei punti macchina: durante il primo pranzo in casa Hoffmeister, la
camera inquadra la scena dalla prospettiva che nel film di Lubitsch era
occupata dalla sedia vuota del giovane caduto, il "posto del morto".
Sceneggiatore fantasma, occulto artefice del casting e benevolo
promotore dell'incontro tra Anna e Adrien, Frantz è in definitiva
l'autentico demiurgo che muove i fili dietro le quinte e che, in un
estremo gesto di annichilimento a vantaggio della sua protegée, si
suicida figuratamente e figurativamente per ridarle di nuovo “envie de
vivre”. La metamorfosi si è compiuta, il bianco e nero funereo si è
finalmente convertito in colore schioccante: Frantz/Adrien/François può
definitivamente eclissarsi e fissarsi in pura immagine, ostacolo ormai
estraneo alla gioiosa vitalità di Anna.
V - Postilla autoreferenziale: coazione a non ripetere

Al
termine di questa smisurata celebrazione della metamorfosi, non posso
fare a meno di interrogarmi brevemente sul limite più insidioso
dell'intero discorso. Se è vero che il cinema di Ozon è rigorosamente
anticonservativo (molto più che anticonvenzionale), è altrettanto vero
che questo rigore ha qualcosa di programmatico e vagamente impositivo.
La celebrazione del movimento trasformativo come fatto irrinunciabile
non rischia forse d'irrigidirsi in norma tanto inderogabile e
costrittiva quanto il protocollo notarile dal quale ci si vorrebbe
smarcare? È questa ipoteca normativa ad apparirmi sempre più chiaramente
come il limite interno (e nascosto) del suo cinema: in forma di domanda
retorica, qual è la differenza tra coazione a ripetere e coazione a non
ripetere?
 "Ispirato a una storia vera, Loving rende omaggio al coraggio e
all'impegno di una coppia mista, Richard e Mildred Loving, innamorati e
sposati nel 1958. La coppia è originaria di Central Point, una
cittadina della Virginia nella quale le comunità si integrano più
facilmente che nel resto del Sud degli Stati Uniti. Eppure è proprio la
Virginia, dove la coppia ha deciso di risiedere e fondare una famiglia,
che prima li condanna alla prigione e poi all'espulsione. Richard e
Mildred si trasferiscono allora coi figli in un modesto quartiere di
Washington. Tuttavia, anche se i parenti li accolgono nel migliore dei
modi, l'ambiente urbano non li fa sentire a casa. Spinta dall'imperioso
bisogno di abitare nella sua regione natale, Mildred trova infine il
modo di tornare in Virginia. Il loro caso giudiziario relativo ai
diritti civili, "Loving contro Virginia", finisce per essere giudicato
dalla Corte Suprema che, nel 1967, riafferma il diritto fondamentale del
matrimonio. Richard e Mildred tornano a casa e la loro storia d'amore è
divenuta, a partire da questa epoca, un modello agli occhi di numerose
coppie" (dal pressbook).
"Ispirato a una storia vera, Loving rende omaggio al coraggio e
all'impegno di una coppia mista, Richard e Mildred Loving, innamorati e
sposati nel 1958. La coppia è originaria di Central Point, una
cittadina della Virginia nella quale le comunità si integrano più
facilmente che nel resto del Sud degli Stati Uniti. Eppure è proprio la
Virginia, dove la coppia ha deciso di risiedere e fondare una famiglia,
che prima li condanna alla prigione e poi all'espulsione. Richard e
Mildred si trasferiscono allora coi figli in un modesto quartiere di
Washington. Tuttavia, anche se i parenti li accolgono nel migliore dei
modi, l'ambiente urbano non li fa sentire a casa. Spinta dall'imperioso
bisogno di abitare nella sua regione natale, Mildred trova infine il
modo di tornare in Virginia. Il loro caso giudiziario relativo ai
diritti civili, "Loving contro Virginia", finisce per essere giudicato
dalla Corte Suprema che, nel 1967, riafferma il diritto fondamentale del
matrimonio. Richard e Mildred tornano a casa e la loro storia d'amore è
divenuta, a partire da questa epoca, un modello agli occhi di numerose
coppie" (dal pressbook).  Largamente ispirato al documentario HBO del 2011 di Nancy Buirski The Loving Story, Loving
racchiude in sé tutti i pregi e i limiti del cinema di Jeff Nichols.
Laconicità drammaturgica, padronanza della narrazione in atti distinti,
controllata scansione della temporalità e, soprattutto, compenetrazione
tra vicende rappresentate e circostanze ambientali: questi punti di
forza del suo cinema confluiscono limpidamente in Loving,
film che fa del radicamento in un'epoca determinata (la storia si
svolge tra la fine degli anni '50 e gli anni '60) e in luoghi ben
definiti (la Virginia, Washington) la propria ragione d'essere. Il
radicamento nel territorio rappresenta difatti l'asse portante del
quinto lungometraggio di Nichols, dal momento che i due protagonisti di Loving
(Ruth Negga/Mildred Loving e Joel Edgerton/Richard Loving) sono
entrambi forgiati e motivati dalla natura in cui sono vissuti - è lo
stesso Nichols a dichiararlo in un'intervista rilasciata a Michel Ciment
e Yann Tobin e pubblicata su Positif: "Penso che se si parla di natura, Loving
è il film più apertamente rivolto verso di essa. È certamente centrale
nei miei film, poiché, secondo me, forma i personaggi che vi hanno
vissuto. Ciò che voi siete è là dove avete vissuto". È d'altronde il
desiderio nutrito da Mildred di tornare in Virginia a costituire
l'autentica motivazione della richiesta di aiuto a Robert Kennedy e,
successivamente, dell'approvazione della battaglia condotta dall'Unione
Americana per le Libertà Civili, rappresentata dal binomio legale Bernie
Cohen (Nick Kroll) e Phil Hirschkop (Jon Bass).
Largamente ispirato al documentario HBO del 2011 di Nancy Buirski The Loving Story, Loving
racchiude in sé tutti i pregi e i limiti del cinema di Jeff Nichols.
Laconicità drammaturgica, padronanza della narrazione in atti distinti,
controllata scansione della temporalità e, soprattutto, compenetrazione
tra vicende rappresentate e circostanze ambientali: questi punti di
forza del suo cinema confluiscono limpidamente in Loving,
film che fa del radicamento in un'epoca determinata (la storia si
svolge tra la fine degli anni '50 e gli anni '60) e in luoghi ben
definiti (la Virginia, Washington) la propria ragione d'essere. Il
radicamento nel territorio rappresenta difatti l'asse portante del
quinto lungometraggio di Nichols, dal momento che i due protagonisti di Loving
(Ruth Negga/Mildred Loving e Joel Edgerton/Richard Loving) sono
entrambi forgiati e motivati dalla natura in cui sono vissuti - è lo
stesso Nichols a dichiararlo in un'intervista rilasciata a Michel Ciment
e Yann Tobin e pubblicata su Positif: "Penso che se si parla di natura, Loving
è il film più apertamente rivolto verso di essa. È certamente centrale
nei miei film, poiché, secondo me, forma i personaggi che vi hanno
vissuto. Ciò che voi siete è là dove avete vissuto". È d'altronde il
desiderio nutrito da Mildred di tornare in Virginia a costituire
l'autentica motivazione della richiesta di aiuto a Robert Kennedy e,
successivamente, dell'approvazione della battaglia condotta dall'Unione
Americana per le Libertà Civili, rappresentata dal binomio legale Bernie
Cohen (Nick Kroll) e Phil Hirschkop (Jon Bass). Eppure,
nonostante questa compenetrazione tra personaggi e spazio che
sembrerebbe suggerire un'apertura della narrazione alle suggestioni
ambientali, Loving è un film chiuso. Chiuso in un
involucro spaziotemporale e in una meticolosità filologica (si veda il
documentario di Nancy Buirski e si prenda atto che Nichols ha girato
svariate sequenze nei luoghi originali della vicenda) che,
paradossalmente, stabiliscono un dialogo ininterrotto col presente
attraverso una domanda implicita che serpeggia costantemente nella
coscienza dello spettatore: "al di là della cruciale questione
giuridica, le cose sono veramente cambiate?". Detto altrimenti, è
proprio in virtù della distanza storica ed estetica esibita dal film che
la relazione con la contemporaneità diventa effettiva e stringente. Ma,
secondo paradosso, questa comunicazione a distanza è ottenuta al prezzo
di una riduzione degli individui messi in scena a organismi vegetali,
piante che, sradicate dal territorio di origine, deperiscono e rischiano
la morte (il piccolo Donald investito da una macchina nella rumorosa e
minacciosa Washington). Una concezione vegetale dell'essere umano
probabilmente più retriva, tradizionalista e immobilista della legge
segregazionista sconfitta dai coniugi Loving e compagnia civile. La
contraddizione tra progresso sociale e regresso vegetale non potrebbe
essere più stridente e sconcertante.
Eppure,
nonostante questa compenetrazione tra personaggi e spazio che
sembrerebbe suggerire un'apertura della narrazione alle suggestioni
ambientali, Loving è un film chiuso. Chiuso in un
involucro spaziotemporale e in una meticolosità filologica (si veda il
documentario di Nancy Buirski e si prenda atto che Nichols ha girato
svariate sequenze nei luoghi originali della vicenda) che,
paradossalmente, stabiliscono un dialogo ininterrotto col presente
attraverso una domanda implicita che serpeggia costantemente nella
coscienza dello spettatore: "al di là della cruciale questione
giuridica, le cose sono veramente cambiate?". Detto altrimenti, è
proprio in virtù della distanza storica ed estetica esibita dal film che
la relazione con la contemporaneità diventa effettiva e stringente. Ma,
secondo paradosso, questa comunicazione a distanza è ottenuta al prezzo
di una riduzione degli individui messi in scena a organismi vegetali,
piante che, sradicate dal territorio di origine, deperiscono e rischiano
la morte (il piccolo Donald investito da una macchina nella rumorosa e
minacciosa Washington). Una concezione vegetale dell'essere umano
probabilmente più retriva, tradizionalista e immobilista della legge
segregazionista sconfitta dai coniugi Loving e compagnia civile. La
contraddizione tra progresso sociale e regresso vegetale non potrebbe
essere più stridente e sconcertante. Ed
è alla luce di questo cortocircuito tra impianto politico libertario e
imprigionante radicamento intimistico (ancora una volta il pubblico
smentisce e mistifica il privato) che Loving evidenzia l'involuzione umanistica del cinema di Jeff Nichols a partire da Mud (2012). Un'involuzione che ha tutti i tratti dell'edulcorazione rassicurante: la paranoia dilagante di Take Shelter
(2011) si è andata diluendo in un umanismo consolatorio ancora
intralciato da grumi genuinamente scorretti e non completamente
addomesticati (ma non bastano le ipoteche di arrivismo che gravano
sull'avvocato rampante Bernie Cohen o le allusioni alla rapacità
mediatica per il caso costituzionale a riscattare Loving dalla parabola agiografica). E se Midnight Special
(2016), il più bello tra gli ultimi tre film del trentottenne regista
dell'Arkansas, conservava comunque una sua oscura carica nomade e
disturbante, Loving segna un ulteriore passo verso il paradiso artificiale del cinema edificante. Un paradiso sempre più simile a una serra.
Ed
è alla luce di questo cortocircuito tra impianto politico libertario e
imprigionante radicamento intimistico (ancora una volta il pubblico
smentisce e mistifica il privato) che Loving evidenzia l'involuzione umanistica del cinema di Jeff Nichols a partire da Mud (2012). Un'involuzione che ha tutti i tratti dell'edulcorazione rassicurante: la paranoia dilagante di Take Shelter
(2011) si è andata diluendo in un umanismo consolatorio ancora
intralciato da grumi genuinamente scorretti e non completamente
addomesticati (ma non bastano le ipoteche di arrivismo che gravano
sull'avvocato rampante Bernie Cohen o le allusioni alla rapacità
mediatica per il caso costituzionale a riscattare Loving dalla parabola agiografica). E se Midnight Special
(2016), il più bello tra gli ultimi tre film del trentottenne regista
dell'Arkansas, conservava comunque una sua oscura carica nomade e
disturbante, Loving segna un ulteriore passo verso il paradiso artificiale del cinema edificante. Un paradiso sempre più simile a una serra.